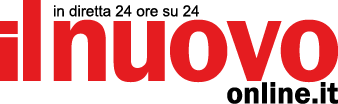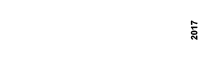Ne segnava il confine, posta all’ingresso della città antica. La bottega di Ninnì accoglieva non solo vecchi avventori, ma si mostrava disponibile anche ai nuovi come me. Tutti sullo stesso piano. Dispensava, con il suo allegro e affabile garbo, i racconti del «grande pelosaro».
L’unica differenza tra i «clientes» si coglieva nella conoscenza del suo soprannome: «lu Zuannutuìllǝ». Per i vecchi, noto e consueto. Per i nuovi, avvolto nella fascinosità della nominazione. Ma, se qualcuno, pronunciava il cognome «Di Bussolo», o il prenome “Nicola”, aveva possibilità pari allo zero per identificarlo. Ninnì era solo Ninnì. Al limite, lo si poteva chiamare Ninnì.
Da quel po’ che son riuscito capire, il suo nome anagrafico era utile solo per la certificazione dello stato civile.
Agli inizi della sua attività lavorativa, da garzoncello del padre (di cui conservava una foto preziosa nel suo “studio” di acconciatore) pareva esserne destinato alla continuità: quella del barbiere.
La stessa che il padre aveva praticato con i colleghi dell’epoca «Nardîććǝ, Passalàcchǝ, Cacabbuśćiuë, Mamàrio», contravvenzionati, tra l’altro, per lavoro oltre l’orario stabilito [e ciò per dare un pane in più alla famiglia (gennaio 1949)]. Memore di questo triste ricordo e niente affatto pago degli esiti sociali di ciò che a Vasto era definita «l’arta liģģìrǝ», Ninnì decideva di migliorare il suo status professionale.
Tal che, con la valigia piena di sogni, volgeva la prora della vita verso Milano per imparare il mestiere che aveva sempre desiderato di apprendere. E così, con la volontà ferrea che lo connotava, dopo poco meno di un anno (a detta sua, sette mesi), tornava nella sua città con il bagaglio professionale caparbiamente acquisito di «coiffeur pour homme».
In questo senso, le antiche barbe da lui fatte fatte nel carcere, in ospedale, nelle case private erano diventate solo un vago ricordo. Quasi non bastasse, alla fine degli anni Cinquanta, la bottega di corso Plebiscito gli consentiva perfino di svolgere l’attività postlavoristica di “pelosaro” (che per lui rappresentava il senso stesso del vivere). In tal modo, le fatiche del padre e della madre Giuseppina, abile pasticcera di pupe e cavalli, erano riuscite a dare il senso più nobile alla sua personalità lavorativa.
Ho frequentato il suo atelier negli ultimi due anni di lavoro. Prima che un male (non so quale) lo rinchiudesse per sempre nel suo nido. Lui, proprio, lui che, tra terra e mare, si muoveva tra gli scogli come uno scoiattolo. Che tra “cerchioni” e “mazzocche” ricavava il buono che la natura gli offriva. E non chiedeva di più. Ho ascoltato i racconti con cui affabulava gli amici sotto il “tosatore” o che attendevano il turno. Un uomo che, nella vita, sapeva pazientare. Un vero peccato non averlo conosciuto prima.
Non averne potuto apprezzare fino in fondo l’umanità. Pazienza. L’importanza sta nell’essersi incontrati.
Buonanotte caro Ninnì. Pensando a te, mi è tornato in mente un aforisma di un grande scultore contemporaneo – Brancusi – che diceva di sé:
«Non sono più di questo mondo, io sono lontano da me stesso, non più legato alla mia persona. Io sono vicino alle cose essenziali»
Sai che cosa credo, mio buon amico? Che il grande Brancusi stesse parlando proprio di te.
Luigi Murolo