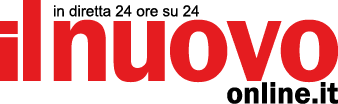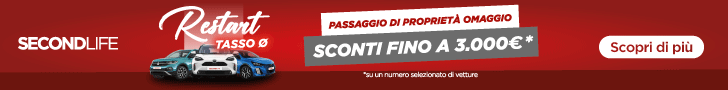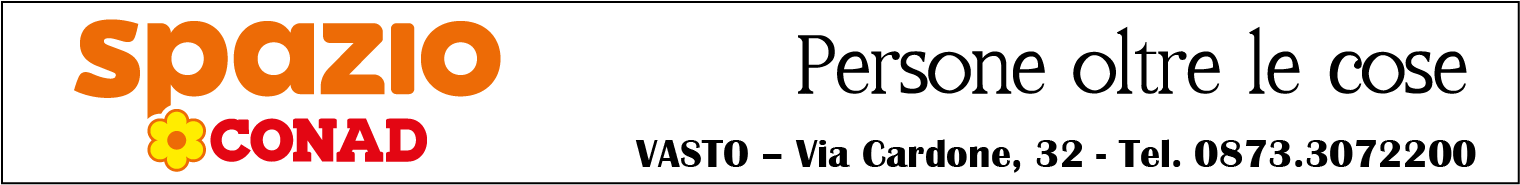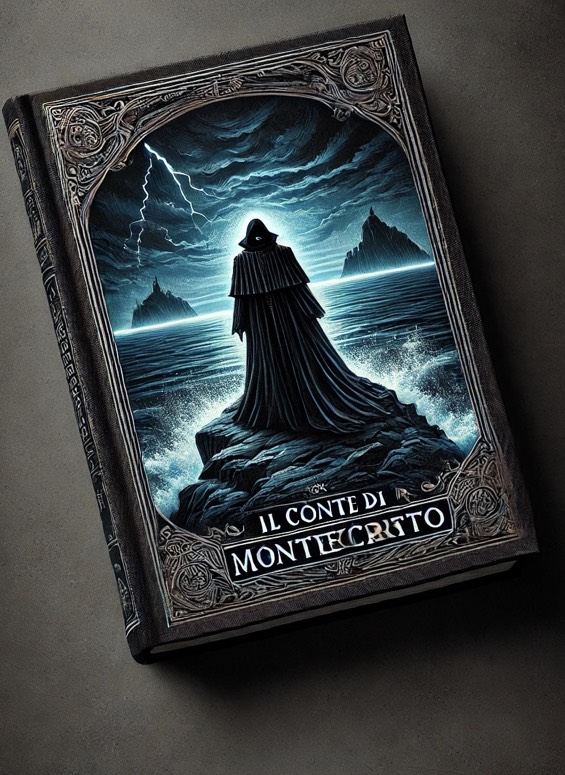
Il nuovo film “ Il Conte di Montecristo” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte presentato al festival di Cannes 2024, e poi mandato in onda sulle reti Mediaset alla fine dell’anno, ha appassionato moltissimi telespettatori scatenando una vera e propria “Montecristomania” e portando, nel giro di pochi giorni, molte librerie a finire centinaia di copie del romanzo di Alexandre Dumas cui è ispirato il film evento.
Potremmo dire che il finale del più recente film sia si rivelato sorprendente, sì, ma solo per coloro che effettivamente già avevano letto il romanzo.
È ormai noto che, talvolta, gli adattamenti cinematografici distano non poco dalle centinaia di pagine scritte che li hanno ispirati. Così chi conosce questi giochi della cinematografia non ha potuto fare a meno di domandarsi se fosse davvero questo il finale pensato da Alexandre Dumas per uno dei conti più famosi anzi, famigerati della storia della letteratura.
Abbiamo cercato di mettere a confronto il finale cinematografico del 2024 ed il finale del libro, evitando gli spoiler più importanti, per coloro che non avessero ancora visto il film oppure letto il romanzo.
Ci siamo chiesti: il finale del romanzo “Il conte di Montecristo” coincide con la versione del film cult del 2024 oppure una realtà moderna e perbenista ne ha determinato una variazione nella storia e nel finale?
Cosa significa “finale perbenista”?
Un finale perbenista tende generalmente ad offrire una conclusione che sia moralmente accettabile o soddisfacente per il pubblico spesso enfatizzando valori come il perdono, la redenzione oppure riconciliazione emotiva.
Tra film e romanzo
Queste caratteristiche nel finale del film di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte ci sono tutte: Edmond al termine della sua avventura affronta un ultimo dilemma morale che culmina in una scelta di perdono e redenzione.
Una componente di riconciliazione che non è così esplicita nel romanzo.
Nel romanzo Dumas è molto più realistico e filosofico. Edmond porta avanti la sua vendetta in modo implacabile e metodico, distruggendo i suoi nemici senza un atto finale di perdono esplicito. Il libro non edulcora le conseguenze morali della vendetta ma appunto si concentra su un’ultima riflessione del protagonista: nonostante la vendetta e la distruzione dei suoi nemici si sia compiuta, non ha trovato la felicità. Dunque l’ Edmond Dantes di Dumas è il classico Homo homini lupus, il cui ultimo atto nel romanzo non è altro che un’ultima riflessione egoistica: tutto quel lavoro, anni di attesa e di meticolosa pianificazione inseguendo il suo lieto fine tanto insanguinato quanto, a suo parere soddisfacente, per cosa? Rimanere con un amaro senso di profonda incompletezza: la sofferenza che lo ha da sempre accompagnato non è svanita: da qui l’ interrogarsi sulle proprie azioni.
“L’uomo più felice è colui che conosce il valore del dolore e ha imparato a sopportarlo.” Dumas lascia che il pubblico tragga le sue conclusioni e faccia i conti con una sensazione quasi ambigua e sicuramente lontana da una riconciliazione completa sia con il protagonista che con le azioni compiute da quest’ultimo.
Nella versione cinematografica Edmond prende coscienza e si libera dal passato: una vera e propria catarsi più netta e soddisfacente rispetto a quella del romanzo, arrivata quasi come un’epifania tanto improvvisa quanto colorata di rosa perché mossa dal potere di un amore passato ma intenso. Così il finale del film cerca di offrire al pubblico il senso di pace e riconciliazione che sembra mancare nel romanzo, a questo punto si potrebbe definire tale finale più perbenista oppure, in alternativa e in chiave più moderna, un’interpretazione più umana e contemporanea del personaggio di Edmond. Nel contesto odierno, un eroe che sceglie il perdono e si libera del peso della vendetta potrebbe essere considerato non tanto perbenista quanto più in linea con la sensibilità del pubblico: la riconciliazione ha un elevato valore narrativo, sebbene per una generazione cresciuta a “pane e vissero tutti felici e contenti” possa rivelarsi un finale tanto piacevole quanto scontato.
Vi lasciamo con l’ultima frase del romanzo di Dumas: “Tutta la saggezza umana si racchiude in due parole: attendere e sperare.” E non è detto che questo rappresenti necessariamente una redenzione completa da parte del Conte, è infatti possibile dare una doppia interpretazione alle parole di Dumas, non una vera e propria presa di coscienza ma un invito alla moderazione, magari una semplice interpretazione ottocentesca delle parole di Confucio: “Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico”.
Laura Del Casale