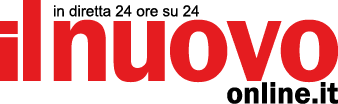Viviamo un tempo complesso. Una delle difficoltà più grandi – forse la più grande – è distinguere la verità dalla narrazione, i fatti dalla confusione. In un’epoca tecnologicamente avanzata, sembra che si sia smarrito il piacere dell’approfondimento, del confronto vero, anche con chi la pensa diversamente. Non si chiede a nessuno di essere esperto in tutto. Ma il minimo che dovremmo esigere da noi stessi, come cittadini, è la capacità di ragionare, di formarsi un’opinione consapevole, fondata.
E invece no: la superficialità delle informazioni prese online ci illude di sapere, ci fa credere di avere la verità in tasca, mentre spesso ci muoviamo in un mondo parallelo, costruito su algoritmi e conferme di comodo. Tutti lamentano la crescente astensione alle urne. Ma pochi si interrogano davvero sulle ragioni profonde di questa rinuncia. Forse perché anche chi dovrebbe ascoltare, coinvolgere, proporre soluzioni, si affida ormai solo ai post, alle stories, agli slogan digitali.
Quanti dibattiti pubblici, incontri reali, assemblee politiche abbiamo visto negli ultimi dieci anni? Pochissimi. Si fa più politica nei gruppi WhatsApp che nelle piazze o nei circoli. Le uniche riunioni in presenza sembrano essere quelle condominiali – spesso con delega, anche lì.
L’8 e il 9 giugno scorsi siamo stati chiamati a votare su cinque referendum importanti: quattro sui diritti fondamentali del lavoro, uno sulla cittadinanza. Vi ha partecipato poco più di 15 milioni di persone. Troppo pochi rispetto ai 25,5 milioni necessari per la validità. Un disastro civico, prima ancora che politico. Ma nessuno, finora, ha avuto il coraggio di aprire una riflessione seria su cosa sia successo. E purtroppo non si tratta di un’eccezione: anche nelle elezioni politiche, regionali e comunali il calo della partecipazione è evidente e drammatico.
Forse abbiamo disimparato a “collettivizzare” i problemi. Forse ci affidiamo più ai “like” che al contatto umano, più all’apparenza social che alla sostanza del confronto. I promotori dei referendum non sono gli unici sconfitti.
Certo, possono aver peccato di presunzione, pensando che il solo nome dell’organizzazione promotrice – il “brand” – fosse sufficiente a mobilitare le coscienze. Magari si è pensato che costruire alleanze, spiegare nel merito le ragioni, fosse tempo perso. Ma non è mai così, soprattutto quando si parla di democrazia diretta. E se anche quei referendum fossero passati, i problemi non si sarebbero risolti automaticamente. Si trattava, ricordiamolo, di referendum abrogativi: avrebbero richiesto comunque un lavoro successivo, una ricostruzione legislativa.
Ora che la consultazione è fallita, vogliamo dire che è colpa di chi “non ha capito”? Vogliamo archiviare il tema dei diritti del lavoro e della cittadinanza solo perché la risposta è stata insufficiente? Serve una riflessione vera. Non per puntare il dito – anche se ogni tanto un bilancio sarebbe utile – ma per decidere cosa fare adesso. Perché il rischio concreto è che questo flop venga usato come pretesto per restringere ulteriormente gli spazi di democrazia diretta: rendere più difficile la raccolta firme, lamentare i costi “eccessivi” per lo Stato, e così via. Il tutto condito dalla solita retorica securitaria, paternalista, autoritaria.
Noi socialisti non ci stiamo. Rifiutiamo la logica dell’arretramento. Rifiutiamo il silenzio. E soprattutto rifiutiamo di sostituire il confronto con la propaganda. A chi ci cerca sui social, diciamo chiaramente: non è lì che ci troverete. Ci troverete dove si discute, dove si costruisce, dove si lotta insieme. Anche – e soprattutto – se la pensate diversamente da noi.
Il Partito Socialista Abruzzese