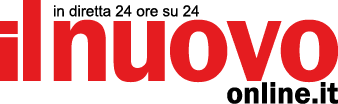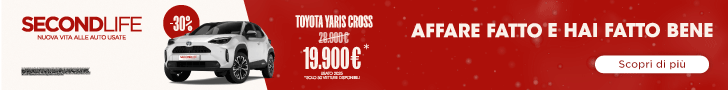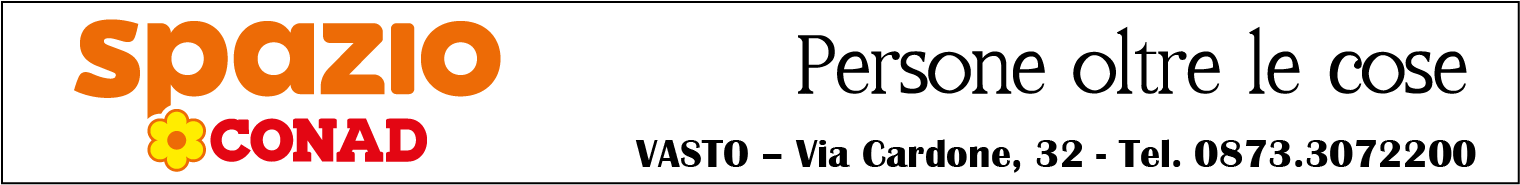Dopo esattamente sei anni dalla dichiarazione di guerra di Francia e Gran Bretagna alla Germania di Hitler e ventiquattro giorni dall’atomica sganciata su Nagasaki, il 2 settembre 1945 il ministro degli Esteri giapponese Mamoru Shigemitsu firma sulla corazzata americana USS Missouri, ancorata al largo di Tokyo, la resa incondizionata del suo paese davanti al generale Douglas MacArthur. Così, come l’Europa occidentale, anche il Giappone entrò a gravitare nell’orbita di influenza americana.
Se un bilancio del costo in termini economici e soprattutto di vite umane è stato da noi fatto nell’articolo dell’8 maggio, quando il Secondo conflitto mondiale terminò sul Vecchio Continente, qui vogliamo parlare della dichiarazione di Ho Chi Minh che diede avvio alla tragedia del Vietnam.
Le origini del conflitto vietnamita e la Conferenza di Ginevra
Al termine della Seconda Guerra mondiale, la Francia voleva riprendere possesso delle colonie strappatele dai Giapponesi, ma incontrò la resistenza dei Viet Minh, organizzazione politico-militare di stampo marxista-leninista fondata nel 1941 con l’obiettivo dell’indipendenza della Penisola da ogni ingerenza straniera. Capo indiscusso e carismatico del movimento fu Ho Chi Minh. Possiamo dire che fu il primo conflitto “per procura” tra Stati Uniti e URSS in quanto i primi appoggiarono con armi e soldi i Francesi, mentre i secondi i rivoluzionari vietnamiti. Cominciò così un primo lungo e sanguinoso conflitto che si concluse con la sconfitta della Francia e la convocazione di una conferenza di pace da tenersi a Ginevra il 21 luglio 1954. All’incontro parteciparono anche USA, URSS e Cina e si concluse con il seguente accordo:
1) La penisola indocinese sarebbe stata smembrata in quattro Stati indipendenti: Laos, Cambogia, Vietnam del Nord e Vietnam del Sud;
2) La linea di divisione tra i due Vietnam fu stabilita al 17° parallelo, la parte nord sarebbe stata controllata dai Viet Minh con capitale Hanoi, quella Sud dagli americani con capitale Saigon;
3) Tale divisione sarebbe stata provvisoria, libere elezioni da tenersi al Sud entro luglio del 1956 avrebbero scelto il destino della parte meridionale della penisola.
Il governo del Sud, con a capo Ngô Đình Diệm sostenuto dagli USA, non permise però le elezioni per il timore di una vittoria comunista, visto il consenso crescente, specie nelle masse contadine, dei Viet Minh.
La ripresa della guerra e l’intervento diretto degli USA
Con il passare del tempo il governo presieduto da Diệm accentuò sempre più la sua natura autoritaria e repressiva specie nei confronti dei Viet Minh rimasti ancora al Sud; a ciò si aggiunse una politica economica ostile ai contadini. Fu così che il governo comunista di Hanoi decise di riprendere la lotta armata rivoluzionaria al Sud con una serie di attentati che portarono all’uccisione di oltre 400 funzionari governativi. Non solo. Nel 1960 nacque il Fronte di Liberazione Nazionale costituito non solo dai Viet Minh ma anche dalla crescente opposizione non comunista al governo di Diem che, a quel punto, si avviava verso la capitolazione. Fu così che gli Stati Uniti, presenti sulla penisola già dal 1950 a sostegno dei Francesi, cominciarono via via a intensificare la loro presenza militare, fino ad un totale di 2.568.000 soldati schierati sul terreno tra il 1965 ed il 1975, oltre ad elicotteri e bombardieri.
La sconfitta statunitense e la riunificazione del Vietnam
Dopo una serie di sconfitte, alcune delle quali umilianti, inferte dalla guerriglia vietnamita capace di attentanti e imboscate nella fitta giungla, nonostante l’utilizzo del famigerato defogliante per scoprire i rifugi dei guerriglieri anti-americani (Viet Cong) e dopo aver lasciato sul terreno 58.269 soldati ed oltre 150.000 feriti, gli Stati Uniti si ritirarono completamente dal Vietnam il 29 marzo 1973, anche se la guerra continuò tra le truppe del Nord e del Sud, fino a quando il 30 aprile 1975 l’esercito comunista di Hanoi entrò trionfalmente a Saigon sancendo la definitiva riunificazione del Paese.
La guerra in Vietnam rappresentò una pesante sconfitta per gli stati Uniti sotto il punto di vista militare, politico e psicologico. Una sconfitta e ancor di più un trauma collettivo raccontato su centinaia di chilometri di pellicola cinematografica.
Laura Del Casale